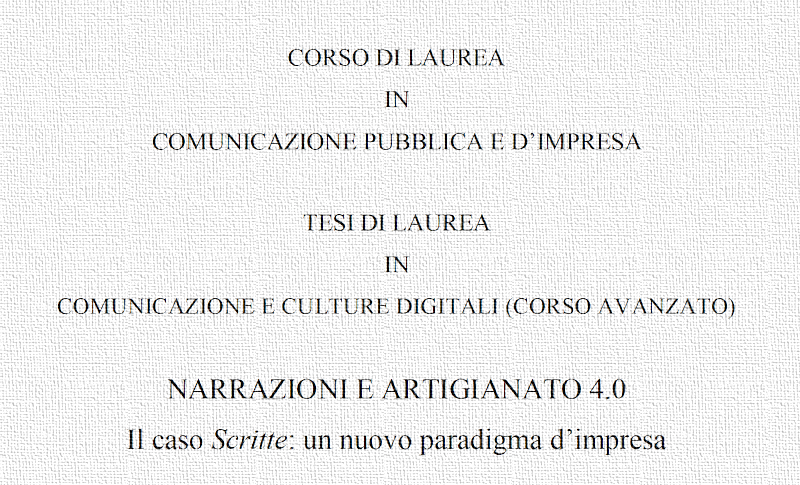CASELLE IN PITTARI, 10 GIUGNO 2021
Caro Diario, nella sua bella storia su Scritte la mia amica Betty Morvillo ha scritto “il senso del mio lavoro è riconoscere i talenti, aiutare i giovani a trasformare i passi in orme, a essere disegnatori e creatori di autenticità e non fotocopie e riproduzioni”. Ecco, nella via versione prof. mi ritrovo molto nelle sue parole e questa sera sono contento assai, perché Nicola Chiacchio ha mandato a Jepis e me, che lo abbiamo seguito insieme a Maria D’Ambrosio, la sua tesi per la laurea magistrale, già il titolo ti riempie il cuore, “Narrazioni e Artigianato 4.0. Il caso Scritte: Un nuovo paradigma d’impresa”, ma è il contenuto che è bello assai e fa la differenza, ma avremo modo di parlarne. Niente, non è che ho particolari meriti nel percorso di Nicola, però il suo talento lo avevo intravisto nell’autunno del 2017 quando gli ho chiesto di raccontarti la sua storia.
Quest’anno lo abbiamo ritrovato in Bottega O, è stato molto attivo, il lavoro che ha fatto su Il mestiere di scrivere di Carver è stato davvero notevole, e poi Casa di foglie e tante altre storie.
Come dici? Peccato che è finita? No, non ancora, fino alla fine dell’anno abbiamo ancora cantieri aperti, ci sarà tempo per parlarne, e magari saranno rose e fioriranno, chi può dirlo. Alla prossima, intanto ti lascio al racconto – biografia di Nicola.

«Caro prof., sono nato nel 1997 alla Clinica Tasso di Napoli che pesavo tre chilogrammi e duecento. Ero pacioccone assai, e infatti così mi chiamava la zia Carmela, spesso pure davanti agli amici, mettendomi ogni volta uno scuorno in faccia mai visto, sì, mi faceva molto vergognare.
A soli dieci mesi, al mio primo Natale, spesso mi ricordano che già recitavo da solo la poesia, in piedi sulla sedia. Gli applausi dei parenti, quelli chi se li scorda. La mazzetta dei nonni? Mai arrivata nelle mani mie. Penso che papà si sia comprato qualche pacchetto di sigarette in più per festeggiare il figlio fenomeno che aveva fatto.
A due anni già al nido, mamma lavorava pure lei in fabbrica. Mi veniva a pigliare zio Raffaele, mio padrino, alle quattro del pomeriggio. Il resto della giornata, fino alla sera, la passavo in fabbrica giù dal nonno. Me ne andavo in giro a curiosare tra scatoloni, suole e macchinari da lavoro. Il nonno teneva una piccola fabbrica proprio giù al suo palazzo.
Erano tempi in cui si faticava assai, quando l’Italia stava bene a soldi come la Germania di adesso, e pure un semplice operaio viveva decentemente. Potevano essere una ventina di loro a lavorare inf abbrica, e ad aiutare papà vicino alla macchina di vernice stava Giulia. Era bella assai Giulia, un pezzo di femmina. Zio Raffaele invece stava nello studio, al computer, che si occupava dei clienti. E in ultimo zio Gianni lavorava vicino al forno. Ricordo che era panzuto zio Gianni, e che mi mandava sempre a fare le commissioni.
«Senti a zio, vai un poco da Santino affianco e fatti dare una bottiglia d’acqua frizzante che poi passo e gliela pago.» Io però mi pigliavo troppo scuorno e dato che papà mi diceva sempre «paga e ringrazia, e non fare mai debiti» una volta dissi allo zio la stessa cosa che mi diceva papà: «zio, io sono andato, ma se non paghi niente acqua».
Vuole sapere come andò a finire caro prof.? Che si presentò in fabbrica dopo un quarto d’ora con il salumiere, che teneva il negozio proprio di fronte, potevano essere dieci metri dal nostro portone. Ovviamente lui aveva negato tutto e vedendomi da lontano che ridevo gli venne naturale dire rivolto a mio padre: «Francesco, ma tuo figlio è proprio un figlio di ‘ndrocchia, lo sai?», il tutto mentre papà se la rideva.
A quattro anni cominciai l’asilo, sono di febbraio, e a casa non mi hanno voluto privare di un anno di giochi, come diceva mamma. La verità è che sono stato quasi sempre più vecchio dei miei compagni di classe. Non a caso, negli anni, spesso ero definito «o’ vicchiariello», il vecchietto. La prima fu la signora Maria che abitava di fianco a noi, ricordo che elogiava assai il mio pormi in maniera matura davanti alle situazioni. Poi fu il turno delle varie comitive avute nel tempo, perché non parlavo molto ma dicevo cose giuste, come gli anziani saggi.
La signora Maria mi metteva sempre a paragone con il figlio, e diceva a mamma: «Come ti invidio, vorrei tenere un figlio come il tuo, che studia e tutto, senza fare casino».
Ci sta un detto che dice che il frutto non cade mai lontano dall’albero e devo dire che mamma non è che abbia fatto i miracoli per mettere al mondo un essere umano così diligente e propenso ai libri. Ho pigliato da papà. Io nello studio metto la stessa passione che mette lui nel lavoro. Teniamo un forte senso del dovere. Infatti se per un giorno, e a volte capita, mi viene da pensare «Ma sì, ma oggi appendo proprio e se ne parla domani», dopo mi sento la coscienza sporca, perché studiare (e qua secondo me ci scappa il linciaggio) per me è un’azione importante come respirare o mangiare. Forse mangiare un po’ di più delle altre, però è per dare l’idea.
A sette anni iniziarono le elementari. A fare i temi ero un fenomeno, con buona pace degli altri. Ogni mercoledì tenevamo due ore di composizione, e puntualmente quando si correggeva il compito, a fine lezione la maestra Annamaria con la penna rossa segnava «super bravissimo, 10!», e nelle giornate buone partiva finanche un applauso. I compiti li ho sempre fatti da solo. Pure perché mamma non è che fosse esattamente una maestra in questo, pure lei viene da una famiglia numerosa ed ha lavorato come sarta per tanti anni. Poi da quando ha conosciuto papà l’avevano messa a cucire le stoffe nella fabbrica del nonno. Ma a scuola diciamo che non ci è andata assai. Quando passano una notizia al telegiornale, sarà che quello dentro alla televisione parla un linguaggio altolocato, ma puntualmente lei capisce una cosa per un’altra e gliela devi spiegare. Mamma a quel tempo era la tipa che quando andavamo a fare i colloqui con le professoresse, lei continuava a chiamarle maestra. “Maestra come va mio figlio, è tutto a posto? Io lo vedo che studia sempre!” e io che mi ingrippavo perché a casa le avevo fatto la scuola, nel senso che le avevo spiegato tutto per bene. «Uè ma tu che vuoi», era la risposta, «io mi scordo che mo’ si chiamano in maniera diversa». Ma il colmo, caro prof., si raggiunse un giorno di un po’ di anni fa, pensi che ogni volta che ci pensiamo non smettiamo di ridere. Stava fuori scuola e le mamme dovevano organizzarsi per comprare il regalo di fine anno alle maestre. Alla sua domanda: “Ma la mamma di C. non viene?”, le risposero: “Non penso, quella tiene un figlio autistico”. E lei, benedetta donna lavoratrice e non scolarizzata, fece: «Ma che dici? Quello il figlio non tiene manco dieci anni e già porta la macchina? Ma non può essere!». Ancora oggi la pigliamo in giro, soprattutto io la sfotto non pocoquando le ricordo il fatto. Vuole sapere la sua reazione prof.? Ride con l’innocenza di chi veramente non tiene colpe.
Detto ciò, mi tocca aggiungere che in quello stesso anno nacque mia sorella e fu la fine di una gloriosa considerazione familiare. Passai dall’essere il nipote preferito della famiglia all’essere il nipote preferito dopo mia sorella. Già da quando i parenti vennero in ospedale notai il nuovo trattamento. Fui io a chiamare la nonna dal fondo del corridoio, perché non sapeva bene dov’eravamo, e quando si avvicinò mi passò davanti senza dire niente per andare a salutare la nuova nipote. Insomma, adesso ero medaglia d’argento, che pure è buono, non crediate, però quando un campione è abituato a trovarsi sempre primo sul podio, ci sta che gli rimane un po’ d’amarezza, o no?
A otto anni pigliavo il primo palo della mia sfortunata esistenza sentimentale. Si chiamava Anna, come mamma. Capelli neri e carnagione scura, bellella, bellina, assai. Quando le mandai il biglietto per fidanzarci con scritto: “Si o no?”, manco mi rispose, lo stracciò direttamente. “Ma tu sei chiatto, grasso, dove vai?”, mi disse poi. Non aveva tutti i torti, però a me piaceva troppo mangiare, non me ne importava di essere chiatto. A volte la incontro ancora, per strada, perché è del paese mio, adesso sta con un pezzo di giovane alto un metro e ottanta, proprio niente a che vedere con me. La verità è che io sono bello dentro, e non lo dico perché sono brutto e devo sopperire a una mancanza fisica per fare fesso il pensiero, sono veramente convinto di essere bello dentro, e credo che chi mi conosce lo possa confermare.
A undici anni arrivavano le scuole medie e io cominciai a rendermi conto dell’esistenza di un atteggiamento da me fino a quel punto parecchio sottovalutato, la cosiddetta cazzimma.
Mio padre, quando sapeva che mi trovavo in mezzo a guai di cui non avevo colpa, me la ripeteva spesso questa parola, ma io non capivo cosa voleva dire, però poi l’ho capito: compagni che ti giurano fedeltà eterna, ma appena arriva l’estate si dileguano; altri che copiano nei compiti in classe, compreso nome e cognome a momenti, ma che poi ti parlano dietro e cose di questo tipo. Fu in quegli anni che cominciai ad alimentare la convinzione di essere nato in un mondo sbagliato. Convinzione maturata sempre di più con il passare del tempo: quella che ‘nu buono guaglione sul pianeta Terra deve tenere per forza una serie di difficoltà.
Qualche anno più tardi avrei scoperto che il sabato sera in certi posti si pigliano sempre tarantelle, si prendono questioni, insomma si litiga prof., non so voi come dite. Che per una ragazza si possono mobilitare pure trenta di loro per una rissa. Che se a quattordici anni non ti droghi ancora, non sei buono, esci per uscire ma per strada non ti conosce nessuno. Io tutti questi fatti non li credevo possibili e quando iniziai a venirne a conoscenza mi si aprì dinanzi agli occhi un mondo nuovo. Una schifezza di mondo a dirla tutta, per me che in ogni cosa ci vedevo quasi sempre solo il lato buono.
A quella stessa età cominciavo il liceo scientifico. Non che mi piacesse assai la matematica, ma stava proprio vicino casa. Gli altri andavano appresso alle ragazze, io un po’ di più appresso ai libri. Forse avevo pigliato la vita troppo sul serio, ma intanto i bei voti a scuola mi gratificavano. Nuovi amici, nuovi spazi, tu che pensi che forse qualcosa va meglio, ed intanto quelli che dovevano essere gli anni più belli volavano così, tra una partita di campionato, una disequazione, una serata chiuso in caso a fare filosofia e la partitella di calcetto con gli amici la domenica sera. Con una cosa che non cambiava mai: la passione per il cibo.
Gli anni della scuola calcio, in cui pesavo come una piuma, erano ormai lontani. Prof., giocavo terzino, e anche se tecnicamente non ero Maradona in campo ci mettevo il cuore. Ho sempre messo il cuore in quello che faccio, e così per una partita sana, nel senso di partita intera, correvo davanti e indietro senza mai fermarmi, che una volta addirittura il mister avversario mi disse «Guagliò ma che tieni nei piedi, ma adesso corri pure per tornare negli spogliatoi?».
Tornando al mio amore per il cibo, ormai ero convinto che niente avrebbe cambiato la mia propensione verso la tavola. Ero tornato il pacioccone di zia Carmela, ma stavolta era grave perché ero grande e mamma non poteva usare più la scusa: “Quello poi fa lo sviluppo e si allunga”.
Poi bello e buono è arrivato l’amore. L’acchiappai in mezzo alla folla che rideva sempre, ma si vedeva che era diversa dalla altre, non me la potevo far scappare. Prima una lunga e profonda amicizia, con me che tra me e me pensavo «stavolta non ti far fare fesso, devi dimagrire se vuoi far colpo».
Lo feci: cento giorni di dieta e quindici chili persi. Da ottantadue a sessantasette. Era estate, tornai carico a settembre sperando di trovare l’amore sotto l’albero di Natale. Tutto bello all’inizio, tutto apposto, ma non durò assai. La distanza, i litigi, un altro. Un altro al posto mio? Non ci volevo credere. È brutto quando tu pensi che una cosa è tua semplicemente perché lo vuoi. Puoi pretendere delle spiegazioni, dei chiarimenti, ma l’amore no, quello non si pretende, se ci sta, ci sta e basta, altrimenti si toglie di mezzo.
E allora ci furono i mesi passati a non mangiare che a momenti si vedevano le costole senza radiografia, gli amici che ti invitano alla serata ma tanto che ci vai a fare, i pensieri vaghi di suicidio sotto ai treni. Bella chiavica. Ma poi passa, meno male che passa. Il tempo è meglio di un dottore certe volte, ti risolve tutti i problemi.
I diciott’anni, i compleanni l’uno dopo l’altro, la maturità. Pigliai 100. Uà, e chi se lo sarebbe mai aspettato? Stavolta mi ero sottovalutato veramente. Gli altri col mio stesso voto a festeggiare, con torte rettangolari enormi e centinaia di invitati manco si fossero sposati, io invece già a ragionare sul prossimo traguardo.
Spesso penso di essere vissuto sempre per ciò che avrei potuto essere dopo, senza godermi i miei momenti di gloria. Lo faccio tutt’oggi, vivo nel futuro e il presente mi sembra già passato, forse perché ho sempre tenuto tanta ambizione, come se dovessi sempre dimostrare a me stesso che valgo più di quello che penso di valere veramente.
«Ma tu che vuoi fare da grande? Ancora non hai deciso niente?». Prima il finanziere, poi il carabiniere. Mio padre, una vita passata in fabbrica, sperava che il figlio si pigliasse un posto statale senza buttare il sangue come aveva fatto lui. Poi un giorno l’illuminazione: «Il giornalista sportivo, faccio quello, perché mi piace tanto scrivere», e la passione per il pallone non mi è mai mancata, effettivamente.
«Ma tu sei sicuro a papà? Non vuoi fare manco la domanda per la Polizia di Stato?”, chiedeva lui, ma io tengo la capa tosta.
E scienze della comunicazione fu. Quando all’ultimo anno di liceo cominciavano a chiedere cosa avessimo scelto, e io spiegavo le mie idee, i professori mi guardavano schifati. «Ma come? Uno come te può ambire a ingegneria, a medicina, e fai quello?» Mo’ vaglielo a spiegare che se devi fare una fatica che non ti piace, ti alzerai ogni giorno della tua vita e la prenderai come una condanna. Che magari loro stessi che stanno dietro a quella cattedra pensavano ad un futuro diverso, poi si sono trovati il posto fisso e si sono accontentati della busta paga invece della felicità.
Io però non la penso così, almeno non oggi, poi va a finire che un giorno mi troverò in mezzo a una strada e mi andrà bene tutto pure a me, chi lo può sapere. Il dottore poi, magari una mattina stai più scocciato del solito vai in ospedale ad operare qualcuno e gli togli la il fegato buono e gli lasci il pancreas malato. Ma per carità, i dottori lasciamoli fare a chi è più sicuro di sé. Che già quando passano il test corrono a scriverlo sui social e pure i genitori si gonfiano la faccia dicendo che poi i figli faranno i dottori, che tengono una capa tanta, nel senso di una grande testa.
Prof., io sono solo un buono guaglione, che la testa preferisce tenerla sopra al collo senza farsi notare più di tanto. Il tipo che a lezione se pure non ha capito, non alza mai la mano che poi gli altri pensano che vuole fare il lecchino nei confronti del professore.
«Ma poi l’università è privata, ce la possiamo permettere?»
In famiglia non mi hanno mai fatto mancare niente, poi il lavoro fortunatamente c’è. O almeno c’era fino a sei mesi fa. E non è tanto normale che tuo padre, dopo quarant’anni in fabbrica si ritrovi per strada, da un giorno all’altro. «Quando i miei amici andavano in gita, io facevo giornata piena a lavoro, e la sera pure i compiti sennò mi mandavano a dormire senza mangiare», spesso mi racconta ancora papà.
In fabbrica ha cominciato che teneva dieci anni. Il nonno aveva bisogno di manovalanza, e quale meglio dei figli che non gli devi dare manco lo stipendio ma solo la mazzetta la domenica mattina per la messa? Mai una gioia, mai un divertimento da ragazzo. Finì le medie e voleva continuare, era appassionato assai del disegno, ma a casa dissero che non andava bene. Poi partì per la leva, andò a Portogruaro, ma arrivavano di continuo telefonate che gli imponevano il ritorno, perché lui faticava tanto senza lamentarsi, quindi serviva troppo giù in fabbrica.
«Se fossi rimasto nei militari ma sai da quanti anni già stavo in pensione?», mi dice quando ripensa a quei momenti. E ora, a cinquantuno anni, con qualche ruga e parecchi problemi alla schiena, si sente pure un po’ incapace perché pensa che ha sbagliato troppo nella vita. Ora al mattino la sveglia non la mettono più in camera da letto, ma la fanno mettere a me. Perché tanto lui adesso può dormire, che si alza a fare presto, mica ci stanno gli operai che aspettano che apre il capannone? Potrebbe, ma in realtà non dorme lo stesso. Quante volte ti alzi per andare in bagno e lo acchiappi con la sigaretta appoggiato alla finestrella che pensa. A chi? A cosa? Al passato? Ai rimpianti? Al fatto che se Dio esiste veramente non doveva finire così? Che non se lo meritava?
Ecco prof., in queste occasioni a vent’anni vorresti essere anche un po’ più uomo e cercarti un lavoro. Ma lui, se lo dici, ti ferma. Perché se devi studiare, devi fa solo quello e farlo bene, tanto prima o poi il sole tornerà a sorgere, la notte mica è infinita.
Adesso ci manteniamo coi risparmi di una vita, che magari sarebbero stati buoni per comprare una casa, una macchina, quando mamma glielo diceva e lui era scettico assai.
«Anna non si sa mai, aspettiamo», diceva alla moglie, e a volte erano tarantelle proprio per queste discussioni qua. Come se poi lo sapesse già che faceva questa fine, se lo sentiva. Ogni tanto mi chiama e mi chiede di controllare sul conto in banca se sono arrivati i soldi della disoccupazione.
«No papà, ho visto ma non ci sta niente.»
«E vabbè, domani ci diamo un’occhiata un’altra volta.»
«Scusa, ma non sai come funziona?»
«E che ne so, è la prima volta che la faccio questa domanda, di queste cose non ci capisco assai.»
E meno male che ogni tanto se ne va a pesca con gli amici, così si distrae. Che pure se è stato una giornata al freddo con la canna in mano, sugli scogli, e non ha preso manco un’alice, si ritira la sera e tiene ancora il sorriso sulla faccia. E dà ottimismo pure a me che, talvolta, ho pensato di fermarmi, pure se fino ad adesso ho dato tutti gli esami. Forse è la paura di studiare una vita sana senza combinare niente di buono al termine di questo percorso che a volte mi blocca.
«Tu non tieni pazienza, ci vuole pazienza assai per fare le cose», mi ripete spesso papà. E in fin dei conti proprio questa sua determinazione nel voler cambiare le cose mi dice che ho un impegno da portare a termine. Per me, per lui, per mamma che mi fa le stesse raccomandazioni mentre sto per uscire di quando tenevo dieci anni. Sì, per lei che si crede che quando vai a ballare la droga te la mettono gratis nel bicchiere. E al solo pensiero che il figlio un giorno se ne potrebbe andare per lavoro sta male.
«Ma poi se fai veramente il giornalista te ne vai a Roma? A Milano?»
«Non lo so mamma, poi vediamo.»
«Ua mio figlio che esce dentro la televisione, che bellezza. Che poi quando ti sistemi io ti vengo a trovare. Quello tuo padre non viene, già lo so, ma io si, mi porto a tua sorella.»
«Senti mamma tu stai già a fare progetti, vedi che è presto ancora.»
A Roma, a Milano, ci metterei la firma. Poi magari finisco a fare le telecronache della squadra del mio paese, che gioca in seconda categoria ed ogni domenica l’arbitro se ne torna a casa con il bernoccolo in fronte se sbaglia a fischiare. Però non me ne importa, sarei contento lo stesso, perché è quello che voglio. Per me stesso, per coloro che mi hanno messo al mondo. Un po’ anche per mia sorella, perché se faccio qualcosa di buono forse mi ripiglio il primo posto. Pure la Pellegrini un paio d’anni è andata male, ma adesso è tornata a vincere ori in quantità, come succedeva un tempo.
Caro prof. questo è, in sostanza, ciò che so di me da vent’anni a questa parte. Delusioni, qualche soddisfazione, tante cose imparate col tempo e un paio di missioni da portare a termine. Una vita da buono guaglione insomma, abbastanza normale, credo.
Ah, dimenticavo un dettaglio non indifferente, che potrebbe portare molti a cambiare totalmente opinione su questa storia. Sono juventino. Si, juventino a Napoli. Ma d’altronde zio Raffaele lo diceva sempre, prima di lasciarci una mattina di dicembre di qualche anno fa per infarto, all’improvviso, a poco più di quarant’anni: Quello mio nipote è gruosso, è un tipo in gamba, però tiene un difetto, tifa Juve. Ma nuje ‘o vulimme bene comunque e facciamo finta che è come noi».

Ecco amico Diario, questa è la storia di Nicola, al quale non fa difetto l’ironia, l’impegno e la voglia di imparare, che come sai non è poco.
Come dici? La sua storia ti è piaciuta un sacco però per essere un napoletano tiene un difetto grande? Uà, mo’ non ti ci mettere pure tu, e che sarà mai, ce ne stanno tanti come lui a Napoli, comprese persone a cui voglio un mare di bene, mica è il solo. Che poi hai visto, anche lì il ragazzo la sa prendere con ironia, e questo è importante. E poi nun me scuccià, come cantava Pino Daniele, che alla fine nessuno è perfetto, neanche tu e io. E questo che cos’è!
Post Scriptum del 19 Dicembre 2017
Caro Diario, oggi sui social ho trovato una bella notizia che riguarda Nicola Chiacchio e l’ho festeggiata con questo post che con grande piacere condivido con te:
«Ora se vi dico che sono felice mi dovete credere. Questo ragazzo qua, Nicola Chiacchio, prima di cominciare il corso con Maria D’Ambrosio and me, ad Ottobre, neanche sapeva che esistevano Luigi Maiello e Intertwine, dopo di che è stato bravo a fare incontrare Intertwine con la sua voglia di raccontare e a Novembre è stato l’autore più letto. Come dite? È solo uno? Innanzitutto non è vero, ce ne stanno altre/i del suo corso che hanno talento e devono solo decidere di fare la fatica necessaria per farlo emergere, ma anche se fosse solo lui per quanto mi riguarda basta a dare più senso al lavoro che faccio. Grazie di cuore Nicola. E voi non perdetevi la sua intervista.»