Questa storia qui è un tuffo nel passato – perché noi lo sappiamo che senza passato non c’è un bel futuro, vero? – che inizia con una bella iniziativa sul lavoro, la memoria, gli archivi e le fonti orali promossa dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio, dal Coordinamento nazionale Archivi, Biblioteche e Centri di documentazione CGIL diretto da Elisa Castellano. Tante belle idee e racconti che si susseguono nel corso della giornata e poi a un certo punto tocca a Ilaria Romeo, Responsabile dell’Archivio storico CGIL nazionale, che nel corso del suo intervento racconta «La nostra vita. Racconti di lavoratori», volume pubblicato nel luglio 1952 dalla casa editrice Lavoro. Ilaria cita la presentazione del volume per ricordare che «i racconti riuniti in questo volumetto appartengono a lavoratori italiani che non fanno professione di letteratura, che anzi, nella maggior parte dei casi, hanno tentato per la prima volta di condensare nella forma del racconto fatti, emozioni e sentimenti della loro vita. Sono stati scritti durante l’ultimo anno, a partire dal maggio 1951, quando il settimanale della CGIL «Lavoro» bandì fra tutti i lavoratori italiani il concorso mensile permanente per un racconto», e aggiunge che dal maggio 1951 al dicembre 1953 la redazione di «Lavoro» riceve circa un migliaio di racconti dai quali sono stati scelti gli undici – più due poesie – che compongono la raccolta.
Non so voi cosa aveste fatto voi al posto mio, io appena Ilaria ha smesso di parlare le ho chiesto se potevo leggere i racconti perché mi sarebbe piaciuto riproporre qui uno, e così lei me l’ha inviato via mail e così io ho deciso di raccogliere una delle indicazioni del curatore – Criticus, così si firma – e di proporre il racconto di Giuseppe Rossi. Posso aggiungere ancora una cosa? Non ve lo perdete per nessuna ragione al mondo.

GIUSEPPE ROSSI
TRAM 41: TORINO STUPINIGI
Chi non conosce, almeno di fama, il castello di Stupinigi? Ma solo chi è di Torino sa che montando sopra la linea 41 è portato dritto e filato sino alla borgata che è sorta accanto al famoso castello reale ideato dal Juvara.
Io facevo sovente quel percorso, un tempo, e anche oggi, ogni tanto, mi capita di rifare quella strada, e ogni volta ricordo …
Ma il mio ricordo è concretizzato ora da un baldo giovanotto che quando mi vede mi salta al collo e strette di mano e saluti da non dire.
‘Sto giovanotto, che si chiama Pino, come me, nacque una mattina di un giorno di dicembre del 1931.
Mi ero alzato alle 3 e mezza quella mattina per via della barba. Mia moglie aveva brontolato nel sonno qualcosa, forse la solita cosa: che facessi piano per non svegliare il marmocchio che dormiva in cucina. La madre previdente, la sera, prima di coricarsi, dalla parte del lettino, aveva coperto la lampada con un mio vecchio berretto da tramviere in modo che la luce non gli ferisse gli occhi.
Mi feci la barba alla cieca, con gli occhi semichiusi, ingollai una tazzina di caffè e, lesto, a piedi, m’avviai al deposito.
Carlin, il collega fattorino, era già arrivato e si stava industriando con le mani intirizzite ad arrotolare la prima sigaretta della giornata.
Aveva nevicato tutta la notte e i pesanti spazzaneve trainati da fumosi cavalli erano già in azione. I cantonieri scendevano dai tram notturni a controllare l’efficienza degli scambi, buttando a piene mani il sale di un color giallastro. Passammo attraverso la città deserta, a velocità discreta. Il cielo era bianco, l’aria quasi tiepida.
– Fiocca! – fece Carlin con tono di scoperta, battendo le palme delle mani sulle braccia per scaldarsi.
Anch’io alzai lo sguardo attraverso il cristallo. Partimmo dall’odierno corso Matteotti con due passeggeri a bordo. Caricai poche persone durante il percorso. Arrivammo a Stupinigi alle 5. C’era già una lunga schiera di operai che vociava e scherzava. I più vecchi stavano muti, il collo insaccato nei loro giacconi, le mani nelle saccocce, ma i giovani alzavano la voce, allegri. Quando arrivai fu un coro di saluti.
Tutti mi conoscevano per nome e io pure. Li cercavo con lo sguardo uno ad uno; di ognuno sapevo qualcosa della sua vita, dei suoi problemi, delle sue speranze. Mancava Nunzio, il napoletano, il più cordiale di tutti, il più simpatico, un giovanottino pareva, magro e bruno, dal viso a coltello e dalla bella voce canora.
– E Nunzio? – domandai.
Mi rispose una donna coprendosi la fronte con la mano.
– Che è successo? – dissi preoccupato.
– La moglie deve avere un figlio – rispose allarmata.
– Via, madama. – feci incoraggiante, – non è poi la fine del mondo!
– Ma la moglie di Nunzio sta male. – protestò quella.
– Lo credo, che diamine, – dissi forte, cercando intorno qualcuno che mi desse ragione.
– Pare stia male sul serio, – fece eco un vecchio che non aveva ancora parlato.
– E’ stato chiamato il medico? – chiesi, tanto per dire qualcosa.
– Il medico … – brontolò il vecchio di malumore.
Non capii se era scontento della mia domanda o di che cosa.
Il fattorino mi batté le mani dalla vettura facendo segni all’orologio.
Ripartii a malincuore, Quella faccenda proprio non mi piaceva. Il Nunzio aveva già un figliolo, all’incirca dell’età del mio: un frugoletto di 7 anni, nero come la pece, con una testa arruffata e due occhi pungenti come spilli. Mi chiamava signor tramviere e voleva ogni volta misurarsi il berretto.
A Porta Nuova non vedevo l’ora che il capolinea mi desse il via della partenza. Partii deciso divorato dall’ansia di sapere e giunsi infatti con cinque minuti di anticipo.
Il crocchio di gente alla fermata stava commentando eccitata e spaventata. Mi fu confermato che la Nunziatina, così chiamavo la moglie del Nunzio, stava realmente molto male. La levatrice aveva detto che ci voleva il dottore.
Dal bar vicino uscì il padrone col grembiule bianco a farmi cenno per il solito caffè che mi offriva ogni mattina quand’ero di servizio sul 41.
– Padrone – mi riuscì appena di dire che un gridò partì dal fondo della strada, un urlo disperato e straziante che mi arrestò la voce in gola e mi diede un’angoscia improvvisa. Era il figlio di Nunzio.
– La mamma muore! – mi urlò il ragazzo, con voce mozza, afferrandosi alle mie gambe.
- la mamma muore! – continuava ad urlare.
Io gli avevo preso la testa con le mani e lo tenevo così, singhiozzante, avvinghiato a me, tutto in un sussulto. Poi mi divincolai e corsi dal Nunzio.
Abitava al fondo d’un cortile ingombro di carretti, casse, masserizie abbandonate. La neve ammolliva i contorni delle cose. Come mi vide il Nunzio mi afferrò per le braccia, stralunato, impazzito pareva, pallidissimo. Mi gridò non so quali parole in dialetto napoletano che io capii a malapena; che le linee telefoniche erano interrotte causa la neve e voleva caricare la sua donna sulla vettura prima che le morisse. Era una pazzia, glielo dissi, cercai di tranquillizzarlo e gli promesi che in un quarto d’ora gli avrei portato il dottore.
Mi precipitai sul tram. Strinsi le mascelle, mollai il freno, e via, la manovella in due scatti del quadrante motore sul 9. Non feci una fermata, il tram lanciato sulle rotaie a 70 all’ora, sino al Mauriziano. Qui frenai bruscamente, con quattro balzi entrai nell’ospedale. Il portiere era un mio conoscente e mi fu facile acciuffare un medico. Ma le due ambulanze erano fuori, mi obbiettò: si presentava il problema del trasporto. Non lo lascia finire. Gli suggerii di preparare i ferri per un eventuale intervento ed io nel frattempo avrei voltata la vettura. Inutilmente Carlin cercò di dissuadermi.
– Costi quel che costi. Carlin – urlai – la responsabilità me la prendo io.
Il bigliettario alzò le spalle, infilò la cicca sopra l’orecchio e s’attacco con le mani alla maniglia dello scambio. Fu una corsa frenetica. La vettura saltava, volava sulle rotaie, velocissima, il mio piede batteva instancabilmente il dischetto della campana in allarme.
Non ebbi animo d’accompagnarlo sin là. Avevo esaurito ogni forza di coraggio. Me ne tornai a Porta Nuova addolorato e confuso, rassegnato a qualsiasi punizione. Spiegai al graduato la colpa del ritardo senza commenti.
Tornai al mio posto, muto. in una disperazione troppo vasta. Pensai a mia moglie, a casa, il bimbo a scuola con la penna chiusa tra le dita e il pennino maledetto che usciva fuori dalle righe.
Rifeci i viaggi senza il coraggio di domandare quel che era successo, se il dottore era arrivato in tempo, soprattutto. Non volevo sapere, non avrei voluto neppure conoscere il Nunzio e il figlioletto dai capelli arruffati, la moglie giovane e sfatta dalla gravidanza con quegli occhi grandi e lucidi che mi fissavano attoniti come sorpresa d’essere al modo, di essere anche lei una creatura di Dio.
Ma alle 10, – era l’ultima corsa e sarei tornato a casa, mentre controllavo al quadrante dell’orologio le lancette senza vederle, sentii una voce amica e commossa che mi chiamò.
Il Nunzio era là, fermo; il dottore affaticato e sorridente, vicino. Mi precipitai e fummo tra le braccia l’uno dell’altro.
– Giuseppe, lo chiamerò, – mi diceva con voce rotta dai singhiozzi, – lo chiamerò Giuseppe come te- – E piangendo mi baciava e mi abbracciava.
– I napoletani sono fatti così, – dissi al dottore scrollando il capo per quasi giustificare a noi, duri piemontesi, quella commozione.
Avviai dolcemente la vettura e guardai fuori gli arabeschi della neve sugli alberi in fila.
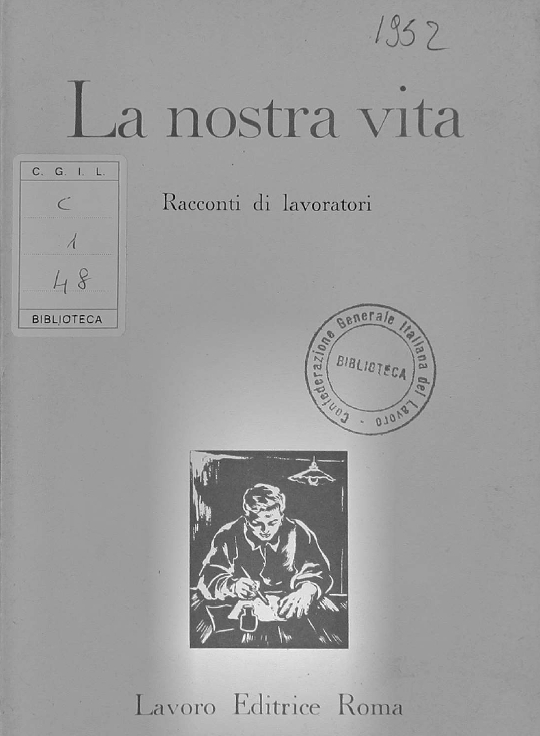
I VOSTRI COMMENTI
Tiziano Arrigoni
Caro Vincenzo, è bellissimo questo racconto, ricorda un ‘Italia essenziale, mi è sembrato di sentire il profumo di quel caffè che il tramviere prende ogni mattina, in questa Torino nevosa. E poi c’è questo gusto per la scrittura, per un mezzo espressivo per acquistare dignità. E siccome come sempre mi fai associare idee, mi fai ricordare il mio paese di origine Massa Marittima, in Maremma, al tempo dei miei genitori, nei primissimi anni Cinquanta, quando al Circolo Cinematografico, promosso da minatori e giovani intellettuali, arrivavano Pratolini e Germi e Lizzani e Luciano Bianciardi e Carlo Cassola. Vicepresidente del circolo sarà anche un giovane minatore massetano, Livio Radi, che troviamo immortalato in una pagina di Bianciardi e Cassola, quasi simbolo di queste nuove speranze, mentre, prima di salire sul pulmann che lo porterà al lavoro in miniera, si rivolge ad una persona della cooperativa: «Domani ti do il racconto. Battimelo a macchina: ce ne vogliono sette copie, per il concorso». «Come, gli chiedemmo, scrivi anche racconti ?». Era arrivato il pulmann e gli operai si andavano radunando lentamente. Radi ci strinse la mano :«Si capisce che scrivo racconti. Perchè ? Volete scrivere soltanto voi due ?». Bello vero?


