Domenica 8 Giugno. Mattino.
Nel mio intervento di cinque minuti a RNext14 Napoli parto da Nuto che ne La luna e i falò di Cesare Pavese dice ad Anguilla che “l’ignorante non si conosce mica dal lavoro che fa, ma da come lo fa”, poi racconto perclavoro-ben-fatto-nessuno-si-senta-esclushé quando fai una cosa non conta quello che fai, quanti anni hai, di che colore, sesso, lingua, religione sei, quello che conta è farla come se in quella cosa dovessi essere il numero uno al mondo, che poi puoi arrivare pure penultimo, non importa, la prossima volta andrà meglio, ma questo riguarda il risultato non l’approccio, nell’approccio hai una sola possibilità, cercare di essere il migliore, e finisco ricordando che noi siamo quelli del lavoro ben fatto, e vogliamo cambiare l’Italia.
Provo a schematizzare: lavoro ben fatto; scelta di mettere sempre una parte di sé in quello che si fa; soddisfazione che si prova a farlo bene; voglia di tenere insieme intelligenza, capacità e passione, testa, mani e cuore, per dare più senso e significato alla propria vita e dare più futuro al proprio Paese.
Lunedì 9 Giugno. Mattino.
Pubblico il testo dell’intervento sul mio blog, che essendo segno zodiacale Vergine nelle cose a cui tengo davvero mi piace essere preciso. Dopo qualche ora me lo ritrovo con piacere pubblicato su CheFuturo!.
Mercoledì 11 Giugno. Mattino.
Mi sveglio con in testa la cavalletta Hopper che in A Bug’s Life dice alla principessa delle formiche, Atta, che la prima regola del comando è: “tutto quello che succede qui è colpa tua”. Ogni tanto mi ritorna in mente questa cosa, secondo me l’idea che la colpa è sempre di chi comanda ha una carica innovatrice straordinaria, la stamperei in 3D e la renderei obbligatoria in tutte le stanze di chi comanda qualcosa, a ogni livello, perché sovverte un modo di pensare, di essere e di fare – quello che porta a dare la colpa sempre a un altro, quasi sempre sotto ordinato nella scala del comando -, assai radicato nella nostra bella Italia.
Certo che lo so che A Bug’s Life non è l’Arte della Guerra, che per quanto mi riguarda Sun Tzu lo farei studiare a scuola assieme a Dante e a La Divina Commedia, ma se Hopper mi ritorna in mente è perché c’è una questione che per mille motivi ho scelto di non affrontare nei miei 5 minuti a RNext14, questa: “Quali caratteristiche deve avere un leader per fare bene il lavoro che deve fare?”.
L’omissione è di quelle importanti, bisognerebbe provare a scrivere profilo e declatatoria del leader, qualunque leader, dal capofamiglia al caposquadra, dal dirigente aziendale al sindaco su su fino al presidente del consiglio, che poi alla fine tanti leader fanno una classe dirigente e una classe dirigente che fa bene il proprio lavoro vuol dire un Paese con più opportunità, con città più vivibili, con più futuro per i suoi giovani.
Sì, uno di questi giorni bisognerà provarci, che magari da soli non ci si riesce ma se ci si mette in tre o quattro chissà. Vedremo.
Mercoledì 11 Giugno. Pomeriggio.
Sui social network continuano ad arrivare commenti, condivisioni, parole di incoraggiamento. Tra i tanti che in vario modo colgono in poche parole più aspetti della questione scelgo in maniera arbitraria quello di Francesco Escalona, che scrive:
“Questa non è una buona idea, questa è l’idea, l’idea rivoluzionaria, l’idea sovversiva, che se entra nella mente e nel cuore della gente cambierà le nostre comunità, cambierà Napoli, e anche di più. E’ solo questione di tempo.”
Sabato 14 Giugno. Mattino.
Su l’Unità Online appare un articolo di Tarcisio Tarquini, La regola morale del lavoro ben fatto nel quale l’Autore, dopo essersi riferito a me, al mio lavoro e al mio intervento a Rnext14, si chiede se questo approccio del lavoro ben fatto possa essere effettivamente esteso dal lavoro artigiano a qualunque tipo di lavoro, in estrema sintesi se il lavoro ha un valore sociale sempre, a prescindere da quello che si fa.
Detto che nel caso ci siate passati solo sopra con il mouse vale la pena cliccare sul link e godere per intero dei colti ragionamenti di Tarcisio, aggiungo qui la citazione da “Il popolo dell’abisso” di Jack London che egli utilizza per chiedere se la regola morale (e generatrice di cultura civile) del “lavoro ben fatto” ammette eccezioni: “Non mi sembra giusto che il lavoratore sia sacrificato esclusivamente in vista dei risultati. Non mi sembra giusto che il lavoratore sia sacrificato sull’altare della mia comodità e del mio orgoglio, o di quelli di una vasta classe composta di persone come me. Preferisco piuttosto che il cotone venga lavorato peggio, ma che in compenso ci siano individui migliori. Il tessitore non dovrebbe venir privato della propria superiorità rispetto al lavoro che compie”.
Sabato 14 Giugno. Pomeriggio.
Su Facebook Bruno Ugolini commenta così l’articolo di Tarcisio:
“Caro Tarcisio, la tua osservazione al pensiero di Moretti sul “lavoro ben fatto” e sul valore sociale del lavoro é senza dubbio fondata. Farei una piccola aggiunta. Io sono convinto (ovvero esperienze del passato e persone come Bruno Trentin mi hanno convinto) che anche il lavoro peggiore, più infernale, possa essere cambiato, introducendo spazi di autonomia e libertà. Non é forse quello che tentavano di fare gli operai delle catene di montaggio, anche italiane, quando con il sindacato si battevano per sperimentare isole di produzione, oppure la multifunzionalità delle mansioni?
Era l’epoca in cui gruppi di estrema sinistra predicavano il rifiuto del lavoro al grido di “a salario di merda lavoro di merda”. Certo non so se, anche per via dei tempi che corrono, il sindacato sia capace oggi di occuparsi di queste cose. Ma sarebbe anche una strada per dimostrare che esiste un modo per aumentare produttività ed efficienza non basato solo sulla riduzione del costo del lavoro.
Mercoledì 18 Giugno. Mattino.
Massimo Chiriatti mi segnala una bellissima poesia di Charles Péguy, si intitola «Il significato del lavoro».
Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano un onore, assoluto, come si addice a un onore. La gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era naturale, era inteso. Era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario, o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura. Una tradizione venuta, risalita da profondo della razza, una storia, un assoluto, un onore esigevano che quella gamba di sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano. Secondo lo stesso principio delle cattedrali. E sono solo io — io ormai così imbastardito — a farla adesso tanto lunga. Per loro, in loro non c’era neppure l’ombra di una riflessione. Il lavoro stava là. Si lavorava bene. Non si trattava di essere visti o di non essere visti. Era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto.
Mercoledì 18 Giugno. Pomeriggio.
Ho una maniera sempre più strana di associare i pensieri, la poesia di Péguy mi fa pensare agli spazzini di Richard Sennett, di Marcelle Padovani e Valeria Lelia de Angelis.
Quello di Sennett l’ho conosciuto in un suo bellissimo libro del 2008, Rispetto (Il Mulino), è proprio lui, lo spazzino, che, parlando del proprio lavoro, afferma: “sono molto soddisfatto quando risalgo la strada che ho appena fatto e la vedo pulita, senza i mucchi di spazzatura che la ingombravano”.
Quello di Padovani e de Angelis l’ho conosciuto da vicino, una domenica piena di sole di un po’ di mesi fa a Piazza del Gesù, quando Marcelle chiede a Valeria la differenza tra il lavoro visto da Napoli, la sua città, e il lavoro visto da New York, la città dove viveva al tempo.
Valeria ci pensa un po’, poi punta i suoi occhioni grandi su Marcelle e le dice “guardi, signora, quando la mattina incontro lo spazzino fuori di casa a New York incontro una persona sorridente, gentile, che mi dà l’idea di essere contenta si quello che fa, quando mi succede la stessa cosa a Napoli incontro una persona insoddisfatta, frustrata, arrabbiata col mondo”.
Confesso che quando Valeria ha aggiunto “credo che questo dipenda dal fatto che nella società americana chi lavora viene rispettato, indipendentemente dal lavoro che fa, mentre qui in Italia, purtroppo, non è così”, sono stato contento, un po’ perché le ragazze come Valeria fanno onore a Napoli, un po’ perché anche io ne sono convinto, è da tanto che incontro Paesi che funzionano così, come nel 2007 a Tokyo, quando è stato Angelo Volpi, al tempo responsabile Scienze e Tecnologie dell’Ambasciata d’Italia, a raccontarmi che in Giappone “non c’è lavoro di cui ci si debba vergognare, lavorare con impegno vuol dire condividere una missione, quella stessa che fa grande la nazione”.
Mercoledì 18 Giugno. Sera.
“A finale”, come dicono i ragazzi della mia bella Napoli, l’idea che mi sono fatto io nel corso delle mie molte vite, quella da sindacalista, quella da dirigente di un’agenzia di formazione, quella da prof. e quella da sociologo, è che a pari condizioni, quali che siano le condizioni, quelli che hanno scelto di fare bene quel che devono fare sono più sereni, più soddisfatti, più in grado di ideare strategie e di adottare comportamenti, individuali e collettivi, in grado di migliorare la loro condizione lavorativa, e dunque vivono vite più degne di essere vissute. A me gli spazzini di Napoli, Londra e New York dicono questo, le storie che incrocio su Le vie del lavoro dicono questo, mio padre questo mi diceva quando mi raccontava che era grazie al fatto che lui il lavoro lo pigliava di faccia che la sera, quando metteva la testa sopra al cuscino, era contento.
Giovedì 19 Giugno. Mattino.
Per me questa storia non può finire qui, bisogna trovare i modi per continuare a discuterne, in tutti i luoghi e con tutte le modalità possibili, dai 140 caratteri di twitter ai post sui blog, dalle mail e dalle note su Facebook a quello che ci pare.
Se vogliamo davvero cambiare l’approccio dell’Italia, se vogliamo ricostruire il senso della nazione intorno al lavoro ben fatto, non possiamo fare a meno di discutere, di fare proposte, di prendere iniziative, ciascuno partendo dal proprio punto di vista e dal proprio lavoro.
Sì, bisogna che nessuno si senta escluso. Studenti, architetti, postini, startupper, scienziati, muratori, maestri, ingegneri, sarti, ebanisti, maker, impiegati, vigili urbani, fabbri, quello che ci pare, accomunati dalla voglia, dalla speranza, dalla necessità di vivere in un Paese nel quale chiunque fa qualcosa, qualunque cosa faccia, cerca di farla bene.
Su, pensiamoci solo per un momento: francesi, giapponesi, americani, tunisini, inglesi, cinesi, sud africani, russi, insomma tutti i popoli del mondo arrivano negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, ai caselli di frontiera, nei porti italiani e trovano il cartello con la scritta “Benvenuti in Italia, il paese dove ogni cosa viene fatta con impegno e passione”.
Diciamo la verità, non sarebbe più bello vivere in un paese così? Ecco, adesso che ci abbiamo fatto il pensiero diciamocelo che non partiamo da zero e neanche da tre, che questa Italia qui c’è, esiste, bisogna “solo” raccontarla, connetterla, valorizzarla di più, farla diventare culturalmente egemone, classe dirigente, l’Italia da ammirare e da imitare, l’Italia dell’intelligenza collettiva, della bellezza che diventa ricchezza, della cultura che diventa crescita economica, della storia che diventa futuro.
#Lavorobenfatto. #Sipuòfare. #Sifa.
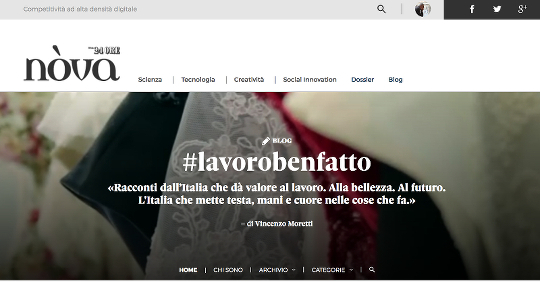 Questo lo avete scritto voi
Questo lo avete scritto voi
Martino Santillo
Gentile Moretti, il suo impegno e la sua costanza sono davvero encomiabili. Credo che insistere sul lavorobenfatto (scritto tutto attaccato) significhi realmente ripartire, e non solo nel lavoro ma nel modo di vivere. Ritengo, infatti, che si tratti per prima cosa di una questione soprattutto etica. Per un ragazzo della mia generazione e soprattutto di questo particolare tempo storico l’incontro con il suo impegno ha realmente il calore di una pacca sulla spalla, quel calore che sorride all’animo e racconta che un mondo diverso è possibile.
Sicuramente non si tratta di una cosa da poco data la rabbia nera che ci portiamo dentro in questi giorni, una rabbia figlia dello spazio che occupiamo dopo anni di studio in cui si è dato tutto, tutto quello che ora sembra perso. Al vedere che chi ha dato il minimo senza il minimo cuore in quel che faceva ora invece insegna, o amministra, o giudica e non ha idea della responsabilità, e del peso del proprio compito né del proprio potere. Proprio mentre sto scrivendo impazza sui social la notizia dei nuovi piani Giannini-Reggi, circa l’aumento dell’orario di lavoro degli insegnanti, e la figura dei dirigenti scolastici che otterranno un “potere fin qui sconosciuto”. Saranno loro, infatti, come riportano i maggiori quotidiani, “a decidere a chi dare i bonus stipendiali”.
Un altro passo dunque verso lo svilimento della figura del lavoratore, e l’aumento del potere di chi gestisce, creando così un sistema clientelare e non meritocratico in realtà.
E se invece l’impegno nel lavoro, nello studio, il valore della responsabilità e dell’amore per quello che si fa! Un po’ di tempo fa un’amica su facebook ha condiviso un pensiero del padre, molto simile a quanto lei esprime nel suo libro, Testa, Mani e Cuore:
“se qualcuno mi dicesse che io faccio male il mio lavoro… non basterebbe un pozzo di 100m di profondità per seppellirmi dalla vergogna! Il problema di oggi è che un politico a cui si dice che sta mandando in malora l’Italia si fa una risata… non capisce che quello è il suo lavoro e lo deve fare bene!”
Se svolgere bene il proprio lavoro fosse un concetto meno razionale, se appartenesse alla sfera dell’istinto, se si dovesse lavorare bene solo perché si deve, perché è giusto a prescindere, perché è etico e politico … beh allora studierebbe chi ama studiare, e chi insegna cercherebbe i contenuti e i modi per far crescere i propri studenti, perché è etico e politico. Chi amministra cercherebbe gli strumenti per mettere chi lavora nelle condizioni migliori per svolgere il proprio mestiere, crescendo come uomo, nella dignità di uomo.
La sua Moretti è una lunga e dura battaglia culturale, che diventa più facile a ogni storia raccontata. Continui dunque a raccontare perché è “etico” credere a un altro mondo possibile.
[dal dizionario Treccani]
Ètica: “ogni dottrina o riflessione speculativa intorno al comportamento pratico dell’uomo, soprattutto in quanto intenda indicare quale sia il vero bene e quali i mezzi atti a conseguirlo, quali siano i doveri morali verso sé stessi e verso gli altri”.
Angela Casale
Lavoro ben fatto per me significa poggiare la testa sul cuscino la sera, con la coscienza a posto. Significa non avere rimorsi né rimpianti. Anzi significa ritirarsi talmente stanchi da aver giusto la forza di salutare la famiglia con un sorriso e mettersi a cena con la famiglia.
Lavoro ben fatto significa potersi guardare intorno con la faccia pulita, gli occhi che mettono ben a fuoco l’obiettivo, il tuo cliente che ti stringe per bene la mano.
Dato il periodo che viviamo non è facile parlare di ciò, non è facile agire, non è facile crederci ancora. Eppure io ci credo, credo al fatto che l’unione fa la forza, credo al fatto che le cose accadono se permettiamo loro di accadere.
Sono convinta che nulla succede per caso, che ogni cosa arriva a suo tempo e che volere fortemente una cosa, fa sì che quella cosa si avveri. Dunque io credo nel lavoro ben fatto ed ogni giorno mi alzo, da gazzella o da leone, affinché ciò che faccio sia curata anche nei minimi particolari. Affinché a mio figlio, un domani, per sapere come va fatta bene una cosa, basterà guardarmi mentre faccio qualcosa. Affinché mentre scrivo, vivo, ci credo, mi alzo e vivo per contribuire al lavoro ben fatto, accada davvero ciò che spero fortemente. Ovvero che qualcosa cambi davvero, che il lavoro ben fatto aumenti, che il lavoro si riscatti dalla situazione attuale, che io vada verso l’indipendenza economica, che tanti altri giovani come me, che combattono ogni giorno, oltre a non abbandonare i loro sogni, si convincano davvero che il lavoro ben fatto significa crescere, vivere dignitosamente, creare il proprio futuro, sposarsi, fare figli ed insegnare ai nostri figli il lavoro ben fatto.
Gennaro de Luca
Ho 24 anni, sono laureato e alla ricerca del lavoro. In verità solo adesso sto riflettendo sul senso del lavoro e soprattutto del lavoro ben fatto. Ho iniziato a pensarci quando ho mosso i primi passi nel mondo del lavoro, ma anche quando con i miei compagni dell’Arci Volla, ho iniziato ad impegnarmi in un progetto sociale.
Io e i miei amici abbiamo iniziato a lavorare con passione, spinti da una malinconica sofferenza, dettata da una carenza di alternative ricreativo -culturali sul nostro territorio. La mia esperienza mi spinge a credere che il lavoro ben fatto è soprattutto una prospettiva personale, una modalità di approcciare le cose.
Quindi credo fortemente che il lavoro lo si debba scegliere, che il lavoro debba nascere da una passione, dalla volontà di realizzare un proprio sogno, un proprio obiettivo, una propria ambizione.
Proprio in un momento storico come il nostro in cui non sempre è facile scegliere il lavoro che si vuole fare, bisogna ancora con più forza affermare che il lavoro ben fatto è l’unico che può nobilitare l’individuo, gratificarlo, farlo sentire parte attiva del contesto sociale in cui vive.
Mario Scippa
Il gesto dell’antiquario è un gesto che si ripete nello stesso modo sera dopo sera, settimana dopo settimana, mese dopo mese. È fatto senza pensare. La mente comanda gli arti, l’abitudine li fa muovere automaticamente nello stesso modo. E’ il gesto di togliere gli oggetti la sera dalla vetrina.
Nel tempo cambiano gli oggetti, ma il gesto no.
Il mio tempo scorre nel negozio, tramandato da generazioni. Quando non viaggio, alla ricerca di un oggetto bello, in quel gesto rivivo sempre lo stesso giorno.
Amo il mio lavoro, l’ho ereditato da mio padre. Come i veri antiquari, che non si improvvisano tali, anche per me questo lavoro è la sommatoria genetica di esperienze delle precedenti generazioni, che risponde ad un’architettura interna dove gli avvenimenti della mia vita e di chi mi ha preceduto, non si sommano o si sovrappongono semplicemente, ma si influenzano, si completano.
Il mio lavoro è il risultato di un prodotto esponenziale di tutte le mie personali esperienze e di chi mi ha preceduto. Tale prodotto può anche ribaltare convinzioni e regole acquisite e date per certezze, perché gli ultimi eventi hanno sempre avuto la potenza di poter trasformare tutto l’insieme.
I miei strumenti di lavoro, sembra strano, ma sono quelli del poeta.
Intanto sono convinto che tutta la vita non è altro che un intervallo di tempo costituito da infiniti frammenti, all’interno dei quali è sempre possibile vivere la bellezza. Inoltre, come in ogni momento della vita, sono anche convinto che la bellezza si può trovarla, inaspettatamente, in ogni oggetto che circonda la nostra esistenza.
Se ne accorge solo chi quando guarda il mondo, lo guarda non solo con gli occhi, ma anche col cuore e la mente: un poeta, o un antiquario.
I poeti costruiscono metafore, immagini che abbelliscono ogni cosa.
L’antiquario ricerca, e mette in risalto per poi venderla, la bellezza negli oggetti di uso comune del passato, altrimenti soffocati dall’oblio del tempo.
Gli antiquari come i poeti vendono la loro personale bellezza, vendono emozioni.
Mio nonno, Don Mario Scippa, era un famoso ebanista napoletano. Mio padre, Raffaele, era un abile ed esperto intagliatore in legno, restauratore sensibile e attento, in età matura e in vecchiaia era stato un antiquario, raffinato e apprezzato, mercante d’arte antica.
Io da bambino, sono cresciuto giocando con mio fratello e i miei cugini tra i trucioli di legno nella vecchia falegnameria del nonno. L’adolescenza, poi, l’ho vissuta nel laboratorio-negozio del padre. Amavo vederlo intagliare il legno. Era affascinato dalle mani di quell’uomo. Passava ore intere accanto a lui, le guardava mentre si muovevano, sicure, durante il suo lavoro.
Erano mani grosse, forti. La destra teneva la mazzuola, un pesante martello di legno con cui dava dei colpi, secchi, forti, allo scalpello che aveva una lama affilatissima e che entrava decisa nel pezzo di legno, sempre cirmolo o tiglio. Erano essenze tenere, legni molto compatti, senza venature, erano usati da sempre per lavori di tornio e intaglio. Erano legni chiari, di colore bianco, sfumato di rosa, con una fibra omogenea e sottile. Legni delicati.
Un gioco di polso, diceva. Il polso comandava il colpo, controllava la forma. Il polso.
Un colpo secco, si staccava un pezzetto di legno, e nell’aria si espandeva un odore forte, aromatico, che solo il legno da intaglio rilasciava quando veniva scolpito. Dal blocco usciva, per incanto, l’abbozzo di una forma. Ricordo che i miei occhi in quel momento preciso, diventavano lucidi, il naso mi bruciava, sgocciolando, per il forte odore del legno appena tagliato.
La notte mio padre si chiudeva nel silenzio. Disegnava riccioli e cartocci, le sue idee per testate da letto o specchiere importanti di stile barocco. Io e mio fratello, facendo finta di dormire, seguivamo come in un sogno, con gli occhi socchiusi, quella matita.
La punta di quella matita scivolava decisa su quei giganteschi fogli di colore giallo pallido, alcuni dei quali ce li ho ancora oggi nel retro bottega del negozio, esposti come importanti cimeli.
Quelle mani, sicure. Forti. Le mani di mio padre, erano lo strumento. Solo con quelle mani si esprimeva, scolpiva. Viveva.
Per Beethoven lo strumento era l’orecchio, per lui le mani. Il grande musicista perse l’udito perché il nervo acustico si atrofizzò. A mio padre, una terribile malattia del sistema nervoso, lentamente, atrofizzò, progressivamente, inesorabilmente, tutti i nervi che portavano vigore e leggerezza ai muscoli del suo corpo, di quelle dita, di quel polso. Lasciandolo morire senza il piacere di poter alzare almeno una mano per salutare i propri cari.
Diventò un corpo consumato, smagrito. Una consistenza fisica metà di qualche anno prima ma che sembrava il doppio, il triplo. Stava diventando immobile. Stava per essere abbandonato dal soffio leggero dell’anima. Uno strumento senza nessuno che lo suonava.
Quel corpo, ai miei occhi, sembrava tutto. Tutto per sempre.
Senza il pensiero, le emozioni, i sentimenti, paure, gioie, dolori, sogni, speranze, senza l’anima, era solo una parte incompleta della persona che io conoscevo come padre. Era la parte pesante, soggetta alla gravità.
Un momento si fissò nei miei occhi, si impresse nella mente e nel cuore come qualcosa che non va più via. Fu il colore della pelle si trasformava, lentamente. Velocemente.
Mio padre non era più. L’anima abbandonò quel corpo. Non era più, per sempre. Sono cresciuto in questo negozio creato da mio padre, tra tavoli in legno, scolpito e dorato, con piani in marmo intarsiato di vari colori, con volute e motivi floreali su fondo bianco di Carrara o giallo di Siena. Da piccolo Giocavo tra tavoli, troni, fregi e quant’altro mio padre poteva trovare di antico. I miei i giocattoli erano frammenti di legno intagliato, i ricoveri di ragazzo felice erano le basi dei tavoli dove mi nascondevo e amavo inventarmi i giochi.
Tutte le esperienze, le conoscenze, ereditate da mio nonno e da mio padre, sommate esponenzialmente alle mie, sono state la base per far diventare il mondo dell’antiquariato, questo mondo complicato e magico, inaccessibile ai più, il mio habitat naturale, nello stesso modo di come lo è una giungla per una tigre.
Liliana Vastano
Mi sono sempre chiesta cosa avrei risposto se qualcuno mi avesse domandato: “Hai fatto sempre bene il tuo lavoro?”
Non lo so, io sono stata un’insegnante, gli insegnanti lavorano con la testa delle persone e la “testa” è un congegno delicato, un intervento sbagliato e puff, può andare tutto in tilt.
Ho fatto saltare qualche testa in trentacinque anni di lavoro? Quante? Spero nemmeno una, non me lo potrei mai perdonare!
Un mio sogno ricorrente, ora che non lavoro più, è quello che mi vede in ansia per le assenze collettive che sottraggono tempo al recupero, alla riflessione, al tempo scuola. E’ forse questo un indizio che ho cercato di fare bene il mio lavoro?
Non lo so, so che mi piacerebbe tanto incontrare tutte le “teste” che hanno interagito con me.
Grazia Coppola
Erre Di era un ingegnere venuto da Milano. Aveva messo tra noi il suo accento e i suoi modi e io devo ancora decidere se mi stava simpatico. Però ricordo una cosa, facevamo con Adriana il giornalino del CRAL per Natale e lui ci diede un pezzo scritto di suo, raccontava una storia che diceva di aver letto da ragazzo.
Tre uomini scalpellano frammenti di roccia per ricavare blocchi di pietra da costruzione, avvicinati da una persona devono rispondere a questa domanda “che stai facendo?” E allora uno, senza alzare gli occhi da terra, dice “non lo vedi? mi sto ammazzando di fatica”, e l’altro “non lo vedi? sto guadagnando il pane per i miei figli”, e l’ultimo “non lo vedi? sto costruendo una cattedrale”.
Erre Di chiudeva le sue righe così: “Buon Natale a chi come me sta costruendo la fabbrica del software più bella del mondo”.
Sì, allora facevo software e ancora come vi ho detto non so se Erre Di mi stesse simpatico o cosa pensare di lui dopo tanti anni, so però che mille volte nella vita c’ho pensato a questa storiella, al lavoro che è sudore e fatica, che ti fa campare, alla fortuna di averlo e l’ho difeso all’occorrenza, ogni singolo minuscolo diritto. e pure l’ho sentita e la sento questa cosa di costruire una cattedrale.
E, come direbbe Erre Di, che lo possino ovunque si trovi, non una qualunque, la più bella del mondo.
Giorgio Fontana
L’idea che un leader debba avere testa, mani e cuore separati, da dove nasce?
Provo a rispondere, innanzitutto chiedendomi se l’arte del comando, sia una scienza e abbia la sua collocazione nella testa, piuttosto che una pratica empirica e sia deputata all’agire delle mani o forse non sia nient’altro che empatia e vaghi, quindi, nelle emozioni del cuore. L’arte del comando è essenzialmente una scienza praticata su altri esseri come te, credo. Come tale appartiene al senso del tragico e come il tragico nasce dalla separazione e dall’esigenza di ricomporre quell’unità separata da entità divine, e non importa che sia la Natura invece che Dio.
In ogni separazione c’è un atto di arroganza che ne fa da levatrice e poi da balia. Arroganza nel far credere che tutto sia razionale e che tutto sia determinato da leggi che prima o poi saremo in grado di, non soltanto, controllare ma perfino di riprodurre, magari con algortimi a cui delegare decisioni, giudizi e imposizioni. Arroganza nel pensare che la migliore scelta sia quella che è già tutta presente nelle cose che sappiamo fare e che ci sono state tramandate dalla tradizione e che non è necessario modificarle e trasformarle. Arroganza nel non volersi assumere la pesante responsabilità di scegliere per il bene comune invece che per quel sangue del tuo sangue che ti stordisce e che non ti permette di decidere.
L’arroganza e la superbia sono come il morbo di Parkinson, un eccesso di neurotrasmettitori che impedisce il comando su di se. Forse nasce da questo stato di catalessi l’idea che si debba tenere separate tra loro questi tre pericolose membra. Ciascuno troppo potente da essere prevaricante, troppo neurodegenerativo tanto da paralizzare ogni altro. Quindi sarebbe meglio che il potere venga esercitato uno alla volta, come volevano i Re Sabaudi.
Ci servono i leader, che sono essi stessi dei membri separati dalla Comunità?
Sono necessari quando hanno il potere di rigenerare le cesure e sono indispensabili quando viene a mancare la connessione tra testa, mani e cuore. Se fosse questa la ragione principale per cui la leadership è necessaria, allora il prescelto non deve mai tenere separati tra loro i tre domini e questo significa che abbiamo bisogno di capire che cosa facciamo, sapere al meglio come farlo ed essere profondamente etici e consapevoli delle conseguenze.
Gennaro Prisco
Quando mi chiedono che lavoro fai, non so bene cosa rispondere. Ne ho fatti tanti di lavori. Li ho amati tutti, anche quelli che ho iniziato a fare per bisogno, anche quelli che hanno messo a dura prova la mia resistenza. Poi incontrai una donna, un insegnante, e capì che il mio lavoro, quello che mi faceva essere felice, non era altro che il narratore di storie. Così sono diventato giornalista e scrittore. Sono diventato cantastorie.
All’inizio avevo timore di non saper parlare, di non saper scrivere. Ancora oggi vivo questa paura. Perché non si può fare il narratore di storie esprimendoti male. Le parole sono parole, sono la struttura del linguaggio e bisogna usarle per quelle che dicono, e quando hanno tanti significati darle il tono giusto, l’esatta inclinazione, espandere il suo valore per poterci ritornare su, perché ogni storia raccontata non è mai completa, non è mai finita.
Il dialogo sullo spazzino di New York e di Napoli, che ci ha offerto Vincenzo, viene ripreso spesso nel dialogo collettivo della narrazione del lavoro fatto bene, perché il quasi bene, non va bene. Così ho pensato a Ciro Scassera, di cui narrerò la storia su Timu, sulle pagine del lavoro narrato.
Ciro è lo spazzino di via Stadera a Poggioreale, ed è uguale uguale allo spazzino di New York. Spazza la via come se fosse il pavimento di casa e quando la fa a ritroso e non c’è nemmeno una cicca a terra sorride al mondo. E la gente lo saluta, lo ringrazia per la cura con la quale distende la sua scopa sotto i marciapiedi, negli angoli più nascosti della strada che è abitata e vissuta e continuamente sporcata. Ciro sgrida chi butta la carta per terra e chi butta la carta a terra prova vergogna, raccoglie la carta, tiene gli occhi bassi.
Ogni volta che ho assistito ad una di queste scene, ho pensato che tanti Ciro cambieranno questo nostro paese. E che sarebbe d’accordo se si scrivesse dappertutto: benvenuti in Italia dove il lavoro si fa bene e con passione, come suggerisce Vincenzo.
Così, anche io, ho pensato alla cavalletta Hopper che dice alla principessa delle formiche Atta, che la prima regola del comando è: tutto quello che succede qui è colpa tua.
Ho pensato a Ciro che dice alla sua scopa e al suo carrello: tutto quello che succede qui è colpa mia.
Antonella Romano
Un lavoro ben fatto richiede, a mio avviso, motivazione.
Che tu sia motivato da esigenze economiche, di affermazione professionale o più genuinamente da passione, poco importa. La motivazione è la scintilla dietro ad ogni successo e “scampato fallimento”.
Le attitudini personali sono senza dubbio rilevanti, ma la motivazione è quel fattore che ti salva anche quando, per un lavoro, non hai una “predisposizione naturale”.
Un esempio concreto potrebbe essere un esame di statistica per uno studente di Lettere e Filosofia che ama la letteratura, i trattati filosofici, la scrittura eppure, al fine di conseguire la laurea, si vede costretto a studiare una materia che è fuori dalle sue corde. La motivazione in questo caso ha un ruolo predominante.
“Se non supero l’esame di statistica, non mi laureo”.
“Se non vendo 10 auto entro la fine del mese, non ottengo il premio di produzione”.
“Se non lavoro 12 ore al giorno, non riesco a pagare la retta scolastica di mio figlio”.
Se vuoi eccellere o semplicemente evitare un fallimento, devi essere motivato e se la motivazione non perviene dal lavoro in sé, il lavoro deve essere quantomeno il mezzo (vendo 10 auto) che ti consente di arrivare allo scopo (premio di produzione).
Amare il proprio lavoro è un lusso di pochi. Avere una forte motivazione è il must di ogni buon lavoratore.
Vincenzo Crolla
E’ domenica. Una di quelle domeniche “per caso”. Passeggiata larga con destinazione Pozzuoli e il suo mercato del pesce per il pranzo serale. Pranzo non cena. Pranzo del pomeriggio, non consumato per l’eccesso di afa del giorno. Senza neppure sapere come, anziché verso la Tangenziale, punti più su, verso i Camaldoli, con lo scopo appena intuito di godere la passeggiata e di giocare al pilota coi tornanti che da Nazareth menano a valle, verso Pianura. I finestrini aperti per l’avversione all’aria condizionata e Leonard Cohen sottovoce, arrivi a Torre Caracciolo e quasi l’hai passata quando un ricordo, come un deja vu, ti assale all’improvviso. E ti blocca.
E’ il ricordo gentile della signora del pane, di quel forno familiare che, quando abitavi a Marano sull’altro versante del Monte Prospetto, visitavi quasi ogni giorno sicuro di trovare ancora il pane. Quello vero. Quello lievitato a mano e tenuto a crescere una notte intera e infornato in vecchi forni di pietra e fuoco di legno di quercia. Con manovra maldestra e poca speranza per i troppi decenni che ti separano da quei luoghi giri il tuo “furgone” e decidi, insieme a Titina, di provare a vedere se laggiù, a Torre Caracciolo, la signora del pane c’è ancora, se ancora delizia centinaia di bocche avide ed esigenti con i suoi giochi di bambina che si diverte con la farina.
Il posto è ancora un garage, come allora; ma ti sembra più lungo, adesso, il percorso che porta all’antico laboratorio in fondo. Entri e già intravedi le due donne, mamma e figlia, come sempre al lavoro. Col sorriso compiaciuto di sempre. Con la soddisfazione che sempre si dipinge sul volto dell’artista che crea davanti alla sua opera.
Pani bianchi, pani integrali, Pani intrecciati, panini napoletani e pizze di ogni specie: margherita, marinara, salsicce e friarielli; e ancora panini “napoletani”, panini imbottiti e mille e mille altre cose.
E’ un trionfo di colori e di odori. Per la delizia dei sensi: della vista, dell’olfatto e del gusto. Ma anche del tatto quando le dita sfiorano la crosta dorata di quelle meraviglie. Il tutto come in un quadro fiammingo con le donne bianche di farina che impastano gli gnocchi adesso e col fuoco del forno che ancora crepita in attesa di un’altra infornata. Con le facce rubizze delle donne cui il fuoco regala un chiaroscuro generoso che, già belle, le fa ancora più giovani e attraenti.
Un regalo questa domenica. Un salto indietro nel tempo che non sfuma e si perde nella nostalgia. Quella nostalgia un po’ rancorosa che a volte si impadronisce del cuore dei vecchi. Un salto indietro in un tempo che è ancora un presente e che attraverso i colori di un Vermeer ti restituisce senza slabbrature un pezzo del meglio di questa città e delle sue donne. Di questa città che sa ancora essere gentile.
Mariarosaria De Vico
Un lavoro ben fatto è quello di una madre che negli stenti e nella miseria rinuncia a tutto pur di mandare il figlio a scuola.
Un lavoro ben fatto è quello del figlio che regala a quella stessa madre la soddisfazione del diploma.
Un lavoro ben fatto è quello del professore che ha insegnato a quel figlio le cose necessarie per conseguire il diploma.
Un lavoro ben fatto è quello della madre del professore che ha rinunciato anch’essa a tutto per consentire al figlio di diventare professore.
Un lavoro ben fatto provoca una reazione a catena di tanti altri lavori ben fatti.
Geremia Pepicelli
Ho letto gli interventi, i pensieri, le emozioni e i commenti e le considerazioni a seguire. Mi sono emozionato, ho iniziato a pensare che forse c’è una speranza se in questo paese c’è tanta gente che la pensa in maniera così positiva e proattiva. Emozione.
Poi sono tornato al lavoro e per tutta la settimana, ogni mattina, mi sono detto: c’è qualcosa che non mi convince in tutto questo; e adesso provo a sintetizzarlo.
Siamo tutti d’accordo e in sintonia; ci diciamo cose importanti, impegnative e cariche di emotività ma che possibilità c’è che ciò faccia si che le cose cambino? Se siamo tutti d’accordo che cosa cambia? Perché mi carico leggendo e parlando di lavoro ben fatto e poi arrivo al lavoro e precipito nello sconforto, in mezzo a sconfortati (ed è un eufemismo)? Perché cerco di fare sempre di più e meglio e non ottengo risultati tangibili? Ma chi dice che quello che io penso sia un lavoro ben fatto e la cosa migliore da fare? Basta porsi nell’ottica auto-legittimante tipo “io faccio le cose bene e con coscienza, come vanno fatte, quindi ho la coscienza a posto e gli altri dovrebbero fare di più e meglio”?
Secondo me non basta e , partendo dalle emozioni, provo a rispondere. Importantissima la risposta della de Angelis alla Padovani sulla differenza di visione tra il lavoro di spazzino svolto a Napoli e a New York: “credo che questo dipenda dal fatto che nella società americana chi lavora viene rispettato, indipendentemente dal lavoro che fa, mentre qui in Italia, purtroppo, non è così”. Bello ed emozionante, ma non basta a cogliere la differenza.
Io lavoro in un’azienda dove si fanno prodotti ad alta tecnologia. Ci sono persone intorno a me che ce la mettono tutta, lavorano per quattro e con un qualcosa in più dei nostri colleghi di altre nazioni, americani compresi. Eppure i nostri prodotti costano di più e sono meno performanti. Così pure i Servizi. Ed è più o meno quello che è possibile osservare in molte aziende italiane.
Per me il motivo per cui questo accade è che mancano i processi, manca il “manuale” a cui ciascuno dovrebbe riferirsi per catalogare il proprio lavoro come ben fatto.
In tutte le grandi organizzazioni, imprese, enti di Paesi all’avanguardia si creano prima le regole di riferimento. Si progettano. Poi si scelgono le persone per metterle in pratica. Gli americani dicono “the best for the job”.
Qui si aprirebbe il capitolo dolente della meritocrazia totalmente assente nel nostro Paese, ma è talmente grosso ed evidente che preferisco rimanere sul tema organizzazione.
Dicevo: Processi=manuale del lavoro ben fatto. Questo è il tema a mio avviso.
Non si può lasciare all’interpretazione e alla sensibilità dei singoli lavoratori. Ci vuole un progetto, lo spartito, poi c’è l’interpretazione. E lasciatemi dire: là non ci frega nessuno! Purtroppo invece la fase progettuale non ci si addice. Noi amiamo improvvisare, senza regole che tanto si fa prima e poi abbiamo “fantasia”.
Non è più così! Il mondo è complicato e così pure il lavoro e non può essere affrontato solo con l’iniziativa personale. Per dirla con linguaggio sportivo ci vuole lavoro di squadra e uno schema efficace. Chiudo questo mio contributo raccontando un episodio accadutomi in Canada molti anni addietro. Ero ad Ottawa per lavoro e al mattino, preso da quelle tipiche smanie di noi italiani all’estero, volevo fare colazione con un cappuccino. Trovato un bel bar dall’aspetto accogliente e confortevole sono entrato e ho notato subito alle spalle della commessa l’elenco di bevande e cibi da ordinare: semplicissimo. Ho chiesto, indicando col dito, il cappuccino e un croissant. Dopo un quarto d’ora al tavolino non arrivava nulla; allora mi sono avvicinato al banco e ho trovato la ragazza immersa in una lettura approfondita di un grosso librone illustrato. Chiedo spiegazioni e mi risponde mortificata che era il primo giorno di lavoro li, stava leggendo come fare il cappuccino e presto sarebbe arrivata. Il cappuccino non era il più buono da me provato ma la ragazza se l’è cavata da sola e con ogni probabilità al pomeriggio era a seguire qualche lezione all’università. Quindi, per me, quando diciamo testa, mani e cuore dobbiamo includere nella testa “organizzazione” e “processi”. Il lavoro è “ben fatto” quando per prima cosa risponde alle regole di progetto ed il plus lo mette il cuore. Le persone non possono essere lasciate sole con l’onere di definirsi le regole del fare bene ma devono sempre avere il manuale a cui riferirsi. Mi scusino artisti, artigiani e tutti quelli a cui tutto ciò è meno affine, ma forse non del tutto estraneo.
Antonio Fresa
Era domenica sera, quella maledetta domenica del 23 novembre 1980. Sì, proprio quella del terremoto, con il suo carico di morti e tragedia. In Campania, nulla fu poi com’era prima.
Abitavamo a Portici, nell’area vesuviana. Non c’era la protezione civile, non si era organizzati: si era soltanto spaventati e impauriti. Mio padre, per rassicurare la mia nonna materna, dichiarò che la nostra casa era stata costruita con criteri ultramoderni. E la nonna venne da noi; e poi i figli (erano tanti) e poi i nipoti (erano tanti). Tante le zie che piangevano domandandosi dove mai si trovassero i loro giovani figli, usciti nel pomeriggio della domenica e non ancora rientrati. Per ognuno che tornava, sospiri di sollievo e ringraziamenti alle potenze del cielo o al fato per la salvezza raggiunta e il pericolo scampato Mia madre quella sera inventò la protezione civile, preparando da mangiare per decine e decine di persone; scaldando latte per quelli che dovevano passare la notte per strada; fornendo assistenza a chi chiedeva. Da allora ho appreso che il mondo si distingue in quelli che si lamentano e in quelli che fanno: e non l’ho mai dimenticato. Questo è nella mia anima il senso di “un lavoro ben fatto”.
Lina Scalea
Per me il lavoro ben fatto non è solo ciò che riesci egregiamente a realizzare nel momento in cui il lavoro… ce l’hai. Non diventa tale dal momento in cui, per meriti o per “fortuna”, riesci ad avere in mano quell’agognato pezzo di carta che ti riconosce e attesta, nero su bianco, che sei diventato un “portatore sano” di status professionale, e un percettore, nel bene o nel male, di un emolumento.
Il lavoro ben fatto è soprattutto quello che il tutto anticipa. Quel variegato e sfaccettato mondo fatto (in ordine sparso e ciclico) di sogni, di aspettative, di mille e sempre diverse paure, di piccole battaglie e grandi guerre. Di quelle ormai note sette, dieci, cento, camice sudate, lavate e indossate ogni giorno e che, lavaggio dopo lavaggio, sembrano assumere di volta in volta, colore e forme sempre diverse. Perché, in fondo, in quel “tutto che c’è prima dell’altro lavoro ben fatto”, non importa quale sia il tuo quotidiano abbigliamento da “fatica”: l’importante è che tu sia in grado di “sudartelo”. Che sudi per raggiungere i tuoi obiettivi, per dare concretezza a quei sogni troppo spesso idealizzati e troppe volte ritrattati tra una camicia e l’altra.
Il lavoro ben fatto è quello che ha fatto tuo padre che per tutta la sua vita si è accontentato, e ha preferito una vita semplice: fatta di piccole cose e la serenità di un lavoro alle dipendenze, regolarmente “indeterminato”.
Il lavoro ben fatto è quella camicia sudata per dimostrargli che potevi osare, che volevi andare oltre quelle piccole cose, che potevi portare a casa il Sogno anche se poggiato su co.co.pro.
Il lavoro ben fatto è quella laurea che pagina dopo pagina, tra gioie e dolori, hai portato a casa tra le lacrime di emozione di tua madre.
Il lavoro ben fatto é quel timore che, alla fine, anche quel pezzo di carta ti avrebbe portato… da nessuna parte.
Il lavoro ben fatto è la decisione di “ritrattarlo” con un prontissimo piano B, che i più attenti provano a chiamare: processo lodevole di “riqualificazione”. Ma tutto sommato, altro non é, che l’ennesima camicia da indossare e stropicciare per benino.
Il lavoro ben fatto è comprare un biglietto di solo andata. É la paura, la scelta di andare, é il sogno che si avvicina, é la frustrazione per il sicuro non ritorno. É il distacco dalla tua storia personale. Perché il lavoro ben fatto è fatto di storie. Di vite. Di storie di sognatori, di appassionati, di assetati di futuro.
Il lavoro ben fatto è quello di chi sceglie di rinunciare al maglione e di chi decide che di quella camicia val la pena farne un credo, spesso dogmatico, ogni giorno.
Michele Somma
Penso che siamo socializzati al lavoro ben fatto fin da piccoli. Sostanzialmente è da questo momento che impariamo che una cosa va fatta bene, dalle due istituzioni educative per eccellenza: la famiglia e la scuola. Se mio padre e/o mia madre fanno bene il loro lavoro, io lo assimilo; se le mie maestre a scuola non si limitano solo a leggere e spiegare, ma vanno oltre, e lo fanno con passione, io imparo che il lavoro va fatto in un certo modo. Impariamo il “lavoro ben fatto” anche semplicemente guardandoci intorno. Se ad esempio chiedo ad un fabbro di montare una cancellata, e questa poi ha difficoltà a chiudersi, vuol dire che il fabbro non ha lavorato bene; se una strada viene asfaltata e dopo un mese si deteriora, causando così incidenti e disagi a chi la percorre, vuol dire che chi ha fatto il manto stradale non lo ha fatto bene!
Nella mia vita per il momento non ci sono state esperienze lavorative, finora ho sempre e solo studiato, e l’ho fatto sempre in un certo modo, con rigore, cercando di metterci la passione anche là dove ne avrei fatto volentieri a meno, avendo però in cambio tante soddisfazioni. Cosa c’entra con il lavoro ben fatto? C’entra perché il lavoro ben fatto va oltre il lavoro come inteso comunemente, è una linea guida, una bussola, un approccio che vale per tutte le cose che facciamo durante la nostra vita. Ed è per questo che può essere un’idea innovativa e, allo stesso tempo, indispensabile, per poter cambiare questo Paese e ritornare a dare valore al lavoro e a chi lavora.
Annamaria Bolli
Parliamone, come no! Io, dal canto mio, cosa posso dire…. Che il lavoro non potrei concepirlo che come “lavoro benfatto”, come impegno serio, sempre e comunque. Si perchè se lavoriamo bene, se ci mettiamo impegno, se ci investiamo “testa, mani e cuore”, facciamo comunque un lavoro di qualità, qualunque esso sia. E bisognerebbe riuscire a lavorare non soltanto per mettere uno stipendio in tasca. Certo, a volte non è facile. E’ umano, anzi, molto umano, sentirsi frustrati quando si fa un lavoro che non corrisponde alle aspettative, o ai desideri, o al livello di istruzione. Ma può essere una sfida, un misurarsi in situazioni non previste, un dimostrare a se stessi di poter affrontare, di sapersi adeguare. E l’impegno, comunque, paga, fosse anche solo per poter essere consapevoli di aver fatto il possibile. Ecco…. fare il possibile…
Giuseppe Ferrigno
Voglio condividere una considerazione, che mi viene dall’ammirazione per il lavoro “ben fatto” che state portando avanti da mesi. Un concetto, questo sul Lavoro, davvero denso di significati, dopo gli anni dei nani e delle ballerine con cui ci hanno inquinato, e che, purtroppo, hanno minato fin nel profondo le faglie della giustizia sociale e della moralità di questo Paese.
“Lavoro ben fatto” per me vuol dire tornare ai veri valori della dignità del lavoratore nello svolgere i propri compiti, vuol dire essere orgogliosi del risultato ottenuto, e “mettere la testa sul cuscino la sera”, come dice Vincenzo, contenti di aver contribuito in qualcosa, che ieri non c’era e oggi c’è, grazie al mio Lavoro.
La considerazione va ai giovani. A quelli con la voglia di fare, agli startuppisti, a quelli che cercano una vita migliore mettendosi in gioco. Il lavoro è fatica, applicazione, dedizione, e orgoglio. Nessuno ci regala nulla, dimentichiamo le scorciatoie del tutto e subito, della start up che ci rende milionari in pochi mesi se colgo l’idea giusta. Certo, può anche succedere, ma il risultato, il successo, si basa, nel 99% dei casi, sulla nostra fatica e sulle energie che investiamo. E’ questo che dobbiamo sempre spiegare ai giovani. E, naturalmente, dargli una mano, a cominciare dai valori. Come state facendo voi. Grazie.
Stefano Nicoletti
Il lavoro ben fatto secondo me ha un’appendice importante: comunicare bene il risultato che si è raggiunto, piccolo o grande, in modo che per tutti o anche solo per qualcuno l’evidenza di quel risultato sia una spinta a fare altrettanto, o almeno a provarci. Ecco, nel corso della mia vita lavorativa ho seguito molti corsi sulla comunicazione efficace. Inizialmente li consideravo perdite di tempo, poi ho capito che la comunicazione tra persone è un passaggio delicatissimo ed è ancora più delicato quando si tratta di far arrivare agli altri fatti nuovi, mentalità diverse, novità totali. Comunicare il #lavorobenfatto attraverso le storie dei loro protagonisti lo trovo un modo coinvolgente, suggestivo e contagioso per tenere vivi e moltiplicare i buoni esempi.
Gennaro Cibelli
La mia storia di acconciatore è iniziata per caso in un salone in auge negli anni ottanta. Ero piccolo, come ha scritto Fred Buscaglione in una sua canzone, e tanta gente tutta insieme mi incuteva timore. Avevo quindici anni, età in cui tutto è favole e fantasia, ma ho imparato molto in fretta, affascinato da questa strada tutta da esplorare, il pianeta del genere umano si esprime anche attraverso i capelli.
Magia: acconciature, colori, mèches, tagli, una carosello di vivacità che ruota intorno all’incontro con la propria bellezza. Capelli, personalità e psiche che si concentrano nella esecuzione di un taglio o un nuovo colore.
Con gli anni e l’esperienza aumentata ho aperto un salone, anni di lavoro tra clienti affezionati e amati. Un giorno nascerà in me il desiderio di scrivere sulle pagine le esperienze condivise con amiche e clienti, riscoprendo l’antico significato del lavoro ben fatto. Buon lavoro a tutti !
Alda Maria Bergomi
Nei giorni scorsi sono stata coinvolta su Facebook in una discussione che, tra le altre cose, riguardava anche l’insegnamento della Storia. Ho insegnato per tanti anni e sono sempre stata molto sensibile al tema della didattica, che, tuttora, ritengo fondamentale, soprattutto nella scuola dell’obbligo. Be’, sono in pensione dal 2005 e non pensavo di potermi ancora tanto appassionare a quello che è stato il mio lavoro di una vita. Lavoro scelto fin da quando frequentavo la IV elementare, per l’ammirazione che nutrii quell’anno nei confronti della nuova maestra. Ho sempre cercato, tra alti e bassi, di svolgere al meglio la mia attività, attività non sempre facile, ricevendone in cambio a volte delusioni, ma anche tante soddisfazioni. Sono giunta alla conclusione che non solo il lavoro artigianale debba corrispondere a certi criteri, ma sicuramente anche altri lavori e, senza alcun dubbio, quello che io ho svolto con tanta passione. Un saluto e….buon lavoro!
Domenico Pennone
Piú per provenienza familiare che per formazione culturale ho sempre pensato che per fare bene il proprio lavoro, occorre usare gli attrezzi adatti. A Napoli abbiamo un modo unico per esprimere questo concetto: Song’ ‘e fierr ca’ fann ‘o mast . Sono i giusti utensili che ti fanno capomastro, ovvero il boss, il capo, il direttore…
Mio padre, che di ferri se ne intendeva, quando lasciai casa tra le tante cose mi diede la famosa cassetta dei ferri per i lavori in casa. Martello, cacciavite, pinze etc. Attrezzi vecchi che conoscevo bene, perché lui mi aveva insegnato a conoscerli. A capire, insomma, che un buon martello con il ferro ben fissato sul legno consente di dare una buona martellata e che, con un cacciavite spuntato, non puoi avvitare mai una piccola vite.
Ho regalato anch’io a mio figlio, che da poco ha lasciato casa, una piccola cassetta dei ferri. Vecchi anche questi e ci ho messo un po’ a spiegargli perché non gli prendevo un’economica cassetta da ikea.
A scuola, da piccolo, ho avuto conferma che la regola dei ferri vale sempre, qualsiasi lavoro fai. Come? Quando con mio enorme dolore mi accorsi che andare a scuola con la penna scarica il giorno del dettato era un errore madornale.
Quando arrivò in ufficio il primo computer tutti lo guardavano con curiosità mista a sufficienza. Io me ne innamorai e ci passai ore a studiarlo. Una sera mi decisi e lo aprii, si, lo smontai, dovevo vedere come era fatto dentro. Poi iniziai a studiare il software, le reti, i cablaggi…
“Ma tu con quei così ci scrivi che te ne frega di come funzionano?” E no, dico io, se vuoi fare bene il tuo lavoro devi conoscere i ferri del tuo lavoro. E così oggi nessun informatico mi dice “non si può fare perché il router o il proxy”. E nessun operatore osa attribuire alla luce una ripresa merdosa, venuta così perché haI dimenticato di “fare il bianco”. Insomma, per me, fare bene il proprio lavoro è anche questo, conoscere ed amare i ferri del proprio mestiere. E anche i ferri del mestiere, qualunque sia il tuo mestiere, si amano con le mani, con la testa, col cuore.
Giancarlo Sciascia
Per me il lavoro è ben fatto quando alla fine ci conosciamo meglio e abbiamo imparato qualcosa insieme, abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato e cosa invece ha funzionato, e magari ce lo diciamo apertamente per fare errori diversi la prossima volta e “giocare” un po’ di più a memoria, alla Cruiff. Lavorare così può essere esaltante ma è molto rischioso. Che tu sia un leader o che tu sia un gregario quel che hai in testa e nel cuore ti può portare a esser riconosciuto come altro rendendoti estremamente vulnerabile nel bene e nel male. Per questo senza umiltà e responsabilità il sensemaking non funziona e il teatro mette in scena maschere senza voce. Il lavoro per me ha senso se risponde a bisogni veri e può aiutarci a risolvere dei problemi o a star bene o a farci delle domande. C’è tanto da fare. Buon lavoro.
Vincenzo Luise
Il lavoro, quello fatto bene, quello dove ci metti la testa, le mani, il cuore, non appartiene al singolo. In quei gesti che siano ripetitivi o creativi, che siano diversi dal mestiere che immaginavi di fare o lo stesso di tuo padre, non ci sei solo tu. Il lavoro ben fatto è il frutto del senso di una comunità. Ho visto quello che dico. Ho visto in una festa popolare tramandare mestieri artigiani che non esistono più. Ho visto anziani insegnare ai giovani i gesti della tradizione, del lavoro quotidiano, gesti che non sarebbero più serviti, ma farlo con passione, con rigore, con cuore. Erano lì, non ad insegnare il mestiere ma a tramandare il modo in cui “si fa” un mestiere, qualsiasi mestiere. E ti rendi conto che il lavoro ben fatto sta nella comunità, sta in quello spazio tra il passato e il futuro. Sta in quella che Ferdinand Tönnies definiva reciproca comprensione. Quella comprensione che è intuitiva come disse Rosenberg. Quella comprensione che ho visto tramandare in quella festa popolare dall’anziano al giovane. Perché quell’anziano non ha mai avuto bisogno di dire “il lavoro lo devi fare bene”. Perché entrambi come parte di una comunità già lo sapevano. Come fosse naturale. Come a sapere che il risultato può anche non venire, ma la differenza sta nel mondo in cui le cose le fai.
Sabato Aliberti
Gli interrogativi posti sono molto interessanti.
Io ho lavorato, come operaio, nelle industrie conserviere a partire dal 1978 e fino agli anni ’90. In quel periodo le “fabbriche” erano organizzate ancora in modo taylor-fordista con la presenza del capo operaio in fabbrica che ti controllava in ogni momento, e del caporalato fuori dalla fabbrica che ti faceva la “grazia” di farti lavorare. Ho vissuto sulla mia pelle la costrizione del fare senza dover pensare, della mortificazione del pensiero e della mia intelligenza, per eseguire mansioni e compiti ripetitivi finanche per 12 ore al giorno.. ed è vero, nel lavoro “ben fatto”, in quelle condizioni, non ravvisavo nessun significato o utilità per me se non quella di “fare senza pensare ma solo per guadagnare”.
Eppure nonostante tutto, pur non avendone strettamente bisogno, ho continuato per più di 10 anni a “produrre ricchezza per altri” e ad attribuire un certo valore al mio lavoro che di anno in anno facevo sempre meglio al punto da riuscire a cambiare anche la mia condizione lavorativa passando da operaio manuale prima, a carrellista dopo fino a conseguire l’abilitazione di conduttore di generatori di vapore negli ultimi anni. Cosa mi ha fatto continuare? Il senso di essere utile, e a volte, persino indispensabile, poiché il lavoro, dopo i primi anni, era diventato una sorta di bisogno vitale che non riempiva solo il mio tempo (e sebbene in minima parte le mie tasche) ma anche il mio animo. Mi sentivo appagato, utile alla mia famiglia sulla quale non dovevo più pesare, alla società, che pur essendo molto giovane, sentivo di contribuire a far crescere. Non erano le mansioni in sé o la tipologia di queste, che pure ravvisavano forti elementi di sfruttamento, che mi facevano continuare, ma una visione etica, quasi spirituale in senso weberiano, del lavoro. L’idea di responsabilità, la sensazione di essere libero e di mediare tra la mia interiorità e il mondo che mi circondava in fondo dava un senso al vissuto che esperivo in fabbrica nell’essere solo pur stando in mezzo agli altri.
In quegli anni mi è capitato di leggere un libro: “I disoccupati di Marienthal” di M Jahoda, P.F. Lazarsfeld e H. Zeisel, dove viene spiegato chiaramente come una completa privazione del lavoro, qualunque esso sia e in qualunque condizione venga svolto, porta a rappresentarsi come una nullità nella vita economica e sociale di una comunità. Dare valore al lavoro secondo me oggi ha ancora più senso che in passato. Basti pensare ad un giovane disoccupato per il quale, nella società odierna, l’unica dimostrazione della sua esistenza sociale, della sua appartenenza ad una comunità sembra essere data unicamente dalla sua iscrizione nelle liste elettorali del comune di appartenenza e dal suo certificato elettorale, quando ogni tre o quattro o cinque anni si presentano alla sua porta e gli dicono che egli ha un ruolo nella vita politica e sociale della comunità. A mio avviso è questo che non ha senso e non ha nessun valore etico!


